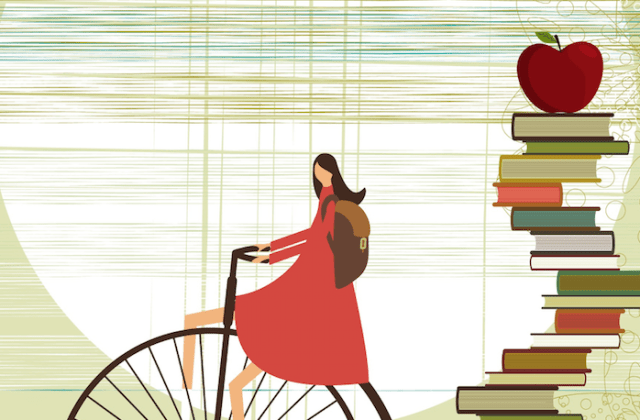Il 24 gennaio, da ormai cinque anni, si celebra la Giornata Internazionale dell’Educazione, una ricorrenza voluta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per dare continuità alla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 ed offrire una piattaforma di dialogo rispetto alle grandi trasformazioni che il mondo dell’istruzione ha non solo subito, ma spesso anche incoraggiato.
Ora, non volendomi addentrare in complesse analisi di quante ragazze e ragazzi nel mondo, soprattutto nei paesi più poveri, vedano ancora oggi negato il loro diritto all’educazione (258 milioni di bambini non frequentano la scuola, 617 milioni non sanno leggere e fare matematica di base, meno del 40% delle ragazze dell’Africa subsahariana completa la scuola secondaria inferiore), mi limiterò a condividere la mia testimonianza di insegnante di scuola secondaria di secondo grado.
Negli ultimi anni, mentre il nostro ruolo mutava lentamente da quello di docenti a quello di educatori, ci siamo convinti che non avremmo più dovuto essere dispensatori di un sapere meccanico, ma formatori di cittadini consapevoli; non più maestri della parola e del confronto dialettico, ma semplici esperti del mondo digitale. Io stessa, pur avendo per anni opposto una ferrea resistenza a questa mutazione genetica del compito dell’insegnante e pur essendomi ostinata ad usare, almeno fino a quando me l’hanno staccata dalla parete, la lavagna di ardesia piuttosto che la famigerata Lim, alla fine mi sono dovuta arrendere, seppur in parte, a questi cambiamenti, anche e soprattutto dopo l’esperienza devastate della didattica a distanza.
Ma proprio gli eventi legati alla pandemia, con una sorta di effetto catartico, hanno portato in particolar modo gli studenti che provenivano da situazioni socio-economiche di grande, se non estrema difficoltà, a richiedere il ritorno alla didattica frontale, quella vecchia, con un professore che racconta il suo piccolo grande sapere e studenti che ascoltano.
Alla mia richiesta del perché non apprezzassero la nuova metodologia di trasmissione dei saperi, la risposta è stata rivelatrice di quanto potente sia, ancora e per fortuna, il rapporto umano fatto di parole, di sguardi e di gesti.
E’ stato bello e confortante al tempo stesso rendersi conto che i loro bisogni educativi passavano, ancora, dall’incanto di una bella lezione in cui si ragiona e ci si confronta tra persone vive, fatte di carne e desideri, dolori e vittorie. Perché questo significa “educare”; questo significa includere.
L’inclusione: un’altra parolina della quale troppo spesso abusiamo. Ma che cosa, chi e come dobbiamo includere? L’unica vera inclusione risiede nel fornire ai ragazzi i giusti strumenti per andare oltre, per superare i propri limiti, per sognare traguardi ambiziosi, per trovare il coraggio ed il desiderio necessari a costruire un futuro diverso dal presente e ricco di contenuti di valore.
Sono assolutamente e profondamente convinta che i cosiddetti “migliori” tra noi docenti dovrebbero essere messi a disposizione delle scuole di frontiera, quelle dove appena entri in aula ti senti respinta a male parole, quelle dove non si hanno competenze linguistiche di base, quelle dove due più due non fa mai quattro. Solo così si potranno formare cittadini consapevoli di avere dei doveri civili e morali verso quei 258 milioni di ragazzi che vedono negato il loro diritto all’educazione.
Claudia De Feo